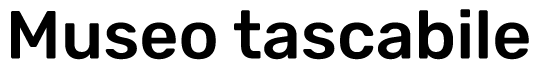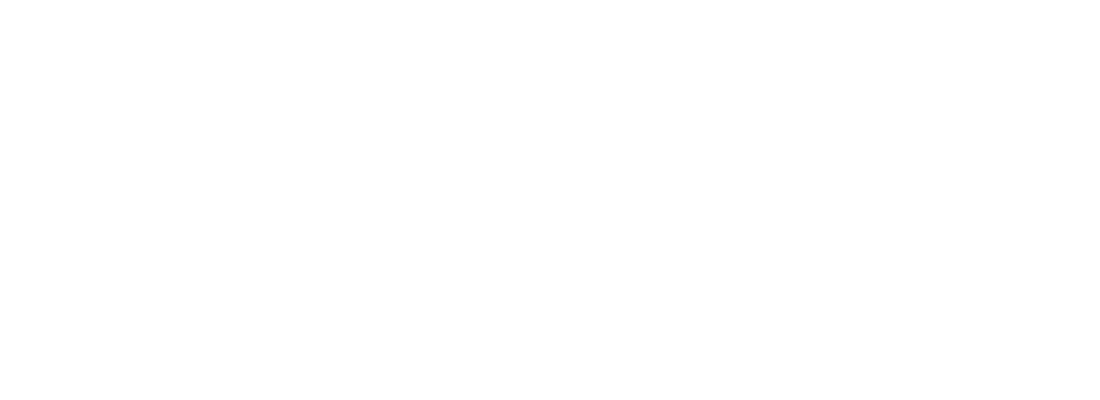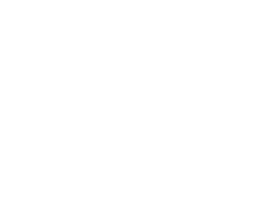G come Guy Hamilton (prima parte)
Fino a un certo punto della saga, i film di James Bond hanno celebrato la Britishness, l’identità culturale britannica. Bond era un’icona tutta inglese, prima di diventare più global e internazionale, un passaggio lento e progressivo che si attua quasi completamente negli anni ‘90.
I primi registi dei film di 007 erano inglesi, di origine o di formazione culturale: Terence Young, il primo regista in assoluto della serie, il maestro che ha definito molti parametri del canone bondiano e ha firmato tre film della serie (Licenza di uccidere, Dalla Russia con amore, Operazione Tuono), era nato a Shanghai ma si era trasferito giovanissimo in Inghilterra con la famiglia e aveva studiato a Cambridge. Lewis Gilbert, noto per Alfie, con Michael Caine, autore di tre film di Bond (Si vive solo due volte, La spia che mi avava, Moonraker- Operazione Spazio), era nato a Londra e soprattutto nei suoi primi film raccontò il modo di essere dell’Inghilterra anni ‘60.
Ma forse chi offrì un ritratto compiuto della Britishnessn fu Guy Hamilton, il regista di Missione Goldfinger e di altri tre film della serie (Una cascata di diamanti, Vivi e lascia morire, L’uomo dalla pistola d’oro).

Anche lui, come Terence Young, si trasferì in Inghilterra da giovane. Nato a Parigi nel 1922, fece lew suew prime esperienze professionali a Nizza, agli studi della Victorine, frequentando i set dei film di Julien Duvivier. Poi per un breve periodo lavorò nella Paramount New Film Library e quindi si arruolò nella Royal Navy. Dopo la guerra, l’esperienza decisiva come assistente di Carol Reed, per due film fondamentali quali L’idolo infranto e Il terzo uomo. Dopo quell’importantissimo momento di formazione, Guy Hamilton iniziò a girare i suoi propri film (nel corso della sua carrierà ne diresse ventidue): si tratta di film molto inglesi, perlopiù ambientati in un contesto molto inglese. Il più suggestivo e riuscito è An Inspector Calls (1954), che racconta i dubbi e i drammi di una solida famiglia inglese dell’upper class, che nell’arco di una notte vede sgretolarsi tutte le proprie solide certezze. Fin da allora Hamilton dimostra di essere un acuto e raffinato osservatore di caratteri e di ambienti: ogni personaggio della storia è cesellato con una cira minuziosa e acuta, e diventa protagonista, una tecnica che il regista seguirà quasi sempre, non facendo sostanziali differenze tra ruoli maggiori e minori. In ogni caso, nella ricca carrellata di ritratti si stagliano quelli interpretati da Alastair Sim nel ruolo dell’ispettore, da Eileen Moore nella parte della figlia del capitano d’industria e da Jane Wenham, nei panni della ragazza di un’altra classe sociale. Altro carattere rilevante che emerge appieno in quel film è l’estrema eleganza conferita da Hamilton ai suoi personaggi: chiaramente il contesto aiuta, ma il regista sottolinea e acuisce i tratti di raffinatezza dei personaggi che mette in scena, cosa che farà sempre.
Prima di An Inspector Calls, Hamilton aveva girato altri due film, The Ringer (1952), la sua opera prima, tratta da un romanzo di Edgar Wallace, con Herbert Lom, e The Intruder (1953), con cui inaugura il ciclo dei film di guerra – altra componente fondamentale nel percorso artistico di vari registi bondiani- cui seguiranno La giungla degli implacabili (1955), incentrato sulla fuga dal castello di Colditz, I due nemici (1962), con David Niven e Alberto Sordi, Tra due fuochi (1964), con Robert Mitchum che indaga sull’omicio di un soldato americano in India durante la Seconda Guerra mondiale, e i lunghi giorni delle aquile (1969), sulla battaglia d’Inghilterra.
L’interesse di The Intruder si deve soprattutto al fatto di aver congegnato un dramma su un doppio registro: l’azione si svolge in parte a Londra, nell’immediato dopoguerra, e sui campi di battaglia. L’abilità di Hamilton sta sia nell’abilità di incastrare nel presente i flashback delle scene di guerra così come nella consueta sensibilità nel mettere a confronto personaggi di differente estrazione sociale, suggerendo tra le righe una critica ai costumi e alle tendenze correnti. Qui il protagonista è Jack Hawkins, un volto molto inglese, nel ruolo di un colonnello sagace e comprensivo (nella sua carriera cinematografica Hawins fu più volte maggiore, colonnello e generale), attorno a cui ruotano tre soldati già alle sue dipendenze.
La ricerca socio-culturale dell’Inghilterra del tempo continua con Charley Moon (1956), la storia di una star dei musical del West End di Londra, e con The Party’s Over (1965), un maliconico ritratto delle sconfitte di un gruppo di beatniks di Chelsea, con Oliver Reed come interprete principale.

Prima, tra il 1957 e il 1959, Hamilton si era cimentato anche con film legati a diversi generi, dirigendo Manuela, con Elsa Martinelli, Trevor Howard e Pewdro Armendariz in una storia d’amore contrastata sulle aque del mare, Il discepolo del diavolo (un filmone storico ambientato nel ‘700, durante la Rivoluzione americana), con un all star cast che comprende Kirk Douglas, Burt Lancaster, Laurence Olivier e Quasi una truffa, una storia di amori e spionaggio, con James Mason e Vera Miles.
Ma nel 1964, prima di The Party’s Over, Hamilton gira un film che è una pietra miliare per la sua carriera e per la storia del cinema: Agente 007-Missione Goldfinger. Non è il caso, qui di fare una lunga disamina di questo caposaldo della saga bondiana. Limitiamoci a dire che Goldfinger, che sta tra tre film di 007 diretti da Terence Young (dopo Licenza di uccidere e Dalla Russia con amore, prima di Operazione Tuono), regala alcune componenti aggiuntive al personaggio e alla struttura del canone.
1) Come si vede subito nella sequenza che precede i titoli di testa, Bond si muove in grandi spazi industriali: certo, era già successo nei laboratori del Dr. No, ma qui l’esuberanza architettonica è valorizzata e esasperata, il complesso industriale tende a sovrastare Bond e l’azione, ambisce a diventare protagonista, e passa in secondo piano solo quando 007 si toglie la muta da sub per rivelare uno smoking bianco immacolato.
2) Hamilton introduce più gadget, inaugurando un nuovo corso dell’armamentario bondiano: l’Aston Martin in dotazione all’agente segreto è super attrezzata e rappresenta un nuovo capitolo nelle invenzioni di Q, dopo la sobria valigetta di Dalla Russia con amore.

3) Bond è ancora più ironico: quando fulmina il suo rivale nella vasca da bagno, con un phon, dice “shocking, positively shocking”, tradotto in italiano con “assolutamente ridicolo”.
4) Hamilton riprende e approfondisce il discorso della diversità di genere, già proposto da Terence Young con Rosa Klebb e con il travestimento di Jacques Bouvar nella sequenza iniziale. Qui un personaggio di prim’ordine è Pussy Galore, la pilota personale di Goldinger, immune al fascino di Bond.
5) Il villain non è un affiliato della Spectre ma lavora in proprio, per il suo interesse personale. Auric Goldinger pianifica il suo folle piano soltanto per appagare la sua passione per l’oro.
6) Hamilton perfeziona il ruolo dell’aiutante del villain, con il maggiordomo coreano Oddjob, micidiale con il lancio della bombetta.
7) Hamilton estremizza alcuni concetti della cultura artistica Pop: esemplare la macabra declinazione della Body Art con la ragazza coperta e soffocata dalla vernice d’oro.
Alcuni di questi punti verranno ripresi negli altri film di 007 diretti da Hamilton, che ritornerà sui set bondiano con Una cascata di diamanti, cui seguiranno Vivi e lascia morire, L’uomo dalla pistola d’oro.
Una cascata di diamanti è uno dei più bei film della serie e forse il più bel film di 007 di Hamilton.
Come ho scritto in James Bond spiegato ai cinefili (Edizioni Il Foglio), Una cascata di diamanti è “un film elegiaco, un’opera che fa propria l’estetica della morte, un lungometraggio concepito come la trasposizione cinematografica di un possente apparato celebrativo barocco, che indirettamente rende omaggio alla defunta signora Bond.
Quel film che celebra una dipartita, saluta anche un momentaneo ritorno, quello di Sean Connery, che interpreta per la sesta volta il famoso agente segreto, dopo una breve interruzione in cui aveva lasciato il posto a George Lazenby. Una cascata di diamanti appare quindi inequivocabilmente un film di passaggio. E lo è ancora di più se si pensa che quel film sancisce la fine del primo tempo del ciclo di Bond, l’era Connery, che con il settimo film della saga si conclude quasi definitivamente (l’attore ritornerà nel 1983 in Mai dire mai, che però rappresenta un capitolo a parte nella serie), per lasciare spazio a un altro stile e ad altri interpreti. Era inevitabile allora che Guy Hamilton, il regista di Una cascata di diamanti, che cinque anni prima aveva firmato Funerale a Berlino, recepisse questi stimoli e li trasponesse nel suo film, una delle opere più marcatamente autoriali della serie.

Curiosamente “il settimo Bond”, venato da un’atmosfera malinconica e lugubre, è contraddistinto da squarci di un’allegria squillante, un po’ camp, che contribuiscono ancor di più a evidenziarne, per contrasto, la natura mesta, intercalata qua e là con qualche guizzo di inventiva postmoderna, prima di ripiegarsi ripetutamente su un andamento elegiaco da lamento funebre.


Una cascata di diamanti, cui è affidato il difficile ruolo di opera di cerniera, è un film profondamente decadente, che inverte la rotta dei primi lungometraggi della serie, soprattutto i primi cinque, poiché già in Al servizio segreto di sua maestà si percepiva un forte senso di incertezza e di malinconia. E’ un film classicamente delirante, uno spettacolo circense travestito da spy story, una versione di un peplum decadente ambientata a Amsterdam e Las Vegas all’inizio degli anni Settanta, un film funereo che parla di deperimento, di dissoluzione, di vertigine (anche metaforica: si veda la scena con la Plenty O’Toole scaraventata dalla finestra dell’hotel Tropicana e, verso la fine, quella dello sballottamento del batiscafo di Blofeld), di perdita degli equilibri”.
Con Una cascata di diamanti Hamilton oltre a far tesoro delle atmosfere del suo Funerale a Berlino (1966), grande classico della spy story, ritorna anche ai suoi esordi con Carol Reed: il senso di decadenza e di disfacimento è quello del Terzo Uomo, e Bond si muove nei condotti sotterranei nel deserto come lo faceva Harry Lime nelle fogne di Vienna.